| |
Torna all'indice di settore
Introduzione
La religione che predomina nella
maggior parte delle nazioni arabe è quella musulmana, prevalentemente sunnita,
nonostante nelle regioni orientali risiedano alcune minoranze sciite.Quasi
ovunque il nazionalismo, emerso alla fine del XIX secolo, ha trovato nell'Islam
un alleato, e in alcuni casi la tradizione religiosa islamica si è trasformata
in uno strumento di potere della classe dominante.
Origine
e diffusione
Vissuto nell'Arabia occidentale
all'inizio del VII secolo d.C., Maometto predicò agli abitanti di quella terra,
in maggioranza seguaci del politeismo, i dettami della nuova fede rivelatagli
direttamente dall'unico Dio, Allah il quale avrebbe consegnato,
tramite l'arcangelo Gabriele, la rivelazione divina destinata a essere
custodita e venerata per sempre dai fedeli. La rivelazione è contenuta nel
Corano, il libro sacro dettato da Dio all'umanità a completamento del messaggio
parzialmente trasmesso sia dalle Scritture ebraiche sia dalle Scritture
cristiane.Nonostante l'ostilità incontrata nella sua città natale, La Mecca,
il profeta riuscì a dar vita, nella città oggi nota come Medina, a una comunità
politico-religiosa che sarebbe riuscita, già prima del 632, anno della morte
del fondatore, a imporre la propria autorità in tutta l'Arabia, nelle città
come fra le tribù nomadi, elevando l'appartenenza all'Islam al ruolo di
elemento di identificazione di una compagine politica unitaria.
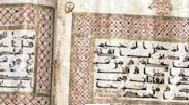
Principale testo sacro dell'Islam, il Corano, suddiviso in 114 sure o capitoli.
L'istituzione del califfato,
mirante a garantire la legittima successione di Maometto alla guida della
nazione islamica, rappresentò l'ambito privilegiato per la trasmissione delle
rivelazioni divine comunicate oralmente dal profeta ai suoi discepoli più
fidati e registrate in forma scritta già all'epoca del terzo califfo Othman
(644-656) nelle 114 sure (capitoli) del Corano, accettate dall'Islam come
definitive e immutabili. I passi del libro sacro costituirono ben presto il
fondamento delle prescrizioni rituali ed etiche della comunità, che tuttavia
accostò alle parole e alle azioni del profeta anche alcune pratiche non
testimoniate dal Corano: questa tradizione parallela, detta in arabo sunna,
rappresenta tuttora una fonte autorevole soprattutto per i sunniti, che vi
scorgono un complemento indispensabile alla rivelazione divina.
Il saldo governo dei califfi
e la fede comune permise i rapidi successi degli eserciti arabi. Questi ultimi,
già prima del 650 sottomisero al dominio del califfato di Medina l'Egitto, la
Siria, l'Iraq e le regioni occidentali della Persia; intorno al 660, con il
passaggio del potere alla dinastia degli Omayyadi, prese avvio la seconda fase
della diffusione dell'Islam, che penetrò nel vastissimo territorio compreso fra
il Marocco e l'Afghanistan, in Spagna e nelle regioni dell'Asia centrale.
Shariah
e i Riti
La professione di fede
in Allah obbliga i seguaci dell'Islam all'osservanza di una serie di norme
etiche e legali che, regolamentando ogni aspetto della vita della comunità,
costituiscono un complesso e minuzioso codice giuridico concepito come modello
ideale per una società teocratica. Identificando infatti la società civile con
la comunità dei fedeli, la teologia islamica innalza il diritto, fiqh
("saggezza"), al rango di scienza religiosa, che deve essere coltivata
dai dotti con la massima dedizione per garantire nel futuro la conformità della
condotta dei fedeli ai principi della legge, la shariah. Gli esperti di
giurisprudenza, detti mufti nella tradizione sunnita e mullah in quella sciita,
legiferano in relazione a ogni aspetto della vita civile e religiosa: essi
elaborano sia le norme del codice penale sia le prescrizioni del diritto di
famiglia, ponendo a fondamento delle loro decisioni non solo i dati del Corano e
della sunna, come si trovano nelle raccolte dei detti e delle azioni del profeta
, ma anche l'orientamento concorde, ijma, di una o più generazioni di uomini di
legge in relazione a una determinata materia; alle indicazioni di questi cultori
del diritto devono attenersi i qadi, i giudici chiamati a pronunciare le
sentenze in merito ai singoli casi loro sottoposti.
Il Diritto Di Famiglia e La Condizione Della Donna
Nell'ambito di competenza
della shariah rientrano anche le norme del diritto matrimoniale. Le nozze per
l'uomo possono avere anche carattere poligamico: alla libertà di sposare fino a
quattro donne si associa l'obbligo di assicurare un identico tenore di vita a
ciascuna delle consorti e ai rispettivi figli. Tale obbligo, soprattutto in
epoca moderna, fa di questa pratica una possibilità limitata agli uomini più
benestanti. Il divorzio, possibile per iniziativa del marito anche in assenza di
particolari motivazioni, può essere ottenuto dalla donna solo per mezzo di una
complessa procedura giuridica, sulla base dello stesso principio che consente il
matrimonio fra un musulmano e una donna di diverso credo religioso, ma impedisce
di dare in sposa una donna musulmana a un uomo non seguace dell'Islam. Per
quanto concerne l'abbigliamento femminile, l'esortazione rivolta dal Corano alle
donne affinché indossino un mantello che copra il loro corpo da capo a piedi
non può essere posta a fondamento della prescrizione di nascondere anche il
volto, introdotta dai califfi Abbasidi (750-1258) con la consuetudine di
confinare le mogli nell'harem, ovvero "luogo interdetto" agli uomini,
consentendo loro di comparire in pubblico soltanto con il volto coperto.
I 5 pilastri dell’islam
Se questa pluralità di
orientamenti costituisce indubbiamente un motivo di tensione nel mondo islamico,
la quasi totalità dei seguaci di questa religione offre invece un'immagine di
profonda unità per quanto concerne l'osservanza dei doveri noti come Cinque
pilastri dell'Islam: alla professione di fede, shahada, nell'unico Dio, il
musulmano deve infatti affiancare la preghiera quotidiana, salat, nelle forme
rituali previste, osservando poi il digiuno, sawm, durante il mese di Ramadan,
oltre a recarsi in pellegrinaggio, hagg, almeno una volta nella vita alla città
santa, La Mecca, e a versare una certa somma di denaro come decima, zakat, a
beneficio dei poveri e della comunità. Obblighi altrettanto sentiti dai fedeli
sono, oltre alla circoncisione maschile, l'astinenza dal consumo di bevande
alcoliche e di carne di maiale, e il rispetto delle norme della macellazione
rituale degli animali delle cui carni è lecito cibarsi.
La preghiera
La preghiera, certamente
la pratica più suggestiva dell'Islam, riunisce per cinque volte al giorno
(soltanto tre fra gli sciiti) l'intera comunità dei fedeli che, ovunque si
trovino, interrompono all'ora stabilita qualsiasi attività per compiere i gesti
di un preciso cerimoniale, rivolgendosi verso La Mecca su un tappeto, limite
dello spazio sacro, a piedi scalzi e in stato di purità rituale dopo una serie
di abluzioni. La preghiera quotidiana viene recitata in forma collettiva nella
moschea, il luogo di culto dei musulmani, dove il venerdì, giorno festivo per
l'Islam, si tiene a mezzogiorno il rito solenne. Oltre alla salat, guidata da un
imam, viene recitata una sorta di omelia pronunciata dal pulpito da un khatib,
figura che comunque non riveste, al pari dello stesso imam, alcuna funzione
sacerdotale in nome del principio della pari dignità di tutti i fedeli di
fronte ad Allah. Al muezzin, forma turca dell'arabo muadhdhin, è invece
affidato l'incarico di annunciare dal minareto, la torre annessa alla moschea,
l'ora della preghiera quotidiana e della funzione del venerdì.
I luoghi sacri
Il luogo più sacro per
i seguaci dell'Islam è certamente la città natale del profeta, La Mecca, dove,
al centro del cortile della Grande moschea, la "moschea sacra" per
eccellenza, si erge la Kaaba, una costruzione cubica, larga circa 10 metri e
alta 15, verosimilmente utilizzata in epoca preislamica come santuario pagano
dagli adoratori della celebre Pietra Nera, un meteorite di 30 centimetri di
diametro che, incastonato in un angolo dell'edificio, è divenuto oggetto di
venerazione anche per i musulmani. Considerando infatti la Pietra Nera come dono
inviato dal cielo per confortare Adamo dopo la sua cacciata dal paradiso, la
tradizione islamica vuole che la Kaaba, edificata da Abramo come luogo dove
chiamare a raccolta tutti i popoli invitati a rendere culto all'unico Dio, fosse
caduta nelle mani dei seguaci del politeismo e dell'idolatria, prima che
Maometto la restituisse alla sua funzione originaria di luogo consacrato alla
pratica del monoteismo.
Oltre a sottolineare la
sacralità di Medina, dove si trova la tomba del profeta, il mondo islamico
tributa da sempre grande venerazione alla città di Gerusalemme, il più antico
fra i luoghi santi del monoteismo; qui Maometto, trasportatovi nottetempo
dall'arcangelo Gabriele, avrebbe conosciuto l'esperienza miracolosa
dell'ascensione ai sette cieli e dell'incontro con i massimi profeti, da Adamo a
Gesù. Grande importanza assumono per gli sciiti, in relazione alle attività
dei loro imam, numerose altre città, come Karbala in Iraq e Qom in Iran.
Il
Ramadan e il Pellegrinaggio Alla Mecca
Facendo decorrere il computo
degli anni dall'Egira, il trasferimento di Maometto dalla Mecca a Medina, il
calendario islamico si articola su un ciclo lunare di 12 mesi non connessi con
il corso delle stagioni. Il nono mese è il Ramadan, il periodo più sacro
dell'anno durante il quale i fedeli osservano scrupolosamente l'obbligo di
digiunare, astenendosi anche dalle bevande e dai rapporti sessuali, dall'alba al
tramonto, per poi celebrare come momento di gioia, alla comparsa della luna
nuova, la festa più importante dell'anno, il primo giorno del mese successivo a
quello del digiuno. L'ultimo mese dell'anno, quello di dhu al-higgia, offre
invece lo spettacolo solenne del pellegrinaggio alla Mecca. Nella prima metà
del mese la città santa viene invasa da una folla sterminata di fedeli che
indossano una veste bianca. Terminate le purificazioni rituali essi procedono
verso il cuore della città, la Grande moschea, dove compiono sette giri intorno
alla Kaaba (il rito si chiama tawaf) e baciano la Pietra Nera, recandosi poi,
come ultima tappa di una corsa frenetica fra le colline, nel piccolo villaggio
di Mina. Esaurita in questo luogo la celebrazione di altri riti, fra i quali una
lapidazione simbolica del diavolo, il pellegrinaggio si conclude, il decimo
giorno del mese, con il sacrificio di animali secondo un cerimoniale imitato nei
tre giorni successivi, quelli appunto della "festa del sacrificio", in
tutto il mondo musulmano.

Quando pregano, i musulmani di tutto il mondo si rivolgono verso la Mecca e, ogni credente che ne abbia i mezzi, deve recarsi in pellegrinaggio alla città santa almeno una volta nella vita. Nella foto, un momento delle cerimonie.
La
guerra santa
Motivo ispiratore comune
per le azioni di queste compagini politico-religiose è il concetto di
"guerra santa" contro gli infedeli, identificati indifferentemente con
i non musulmani e con i membri della comunità islamica considerati traditori a
motivo delle loro posizioni progressiste e filo-occidentali. A questo proposito
occorre precisare che il termine arabo jihad, nel quale non solo la cultura
occidentale, ma anche qualche settore dello stesso integralismo islamico, tende
a cogliere la definizione della guerra santa come dottrina essenziale
nell'Islam, nel Corano ha un'accezione più ampia: jihad significa infatti
"sforzo" e il libro sacro, considerando come sforzo maggiore sulla via
di Dio l'impegno del fedele a vincere le proprie tentazioni per divenire un buon
musulmano, presenta la guerra santa contro gli infedeli soltanto come dovere
minore da compiersi in circostanze ben precise sulla base di una rigorosa
definizione giuridica. Non si deve dimenticare inoltre che, per quanto l'Islam
sia penetrato fino in Europa come conseguenza della forza espansionistica
dell'impero ottomano dal 1300 alla fine della prima guerra mondiale, il diritto
musulmano non ha mai previsto, di fatto, l'imposizione della fede islamica
attraverso la guerra, tenendo distinti i successi militari dei popoli arabi
dalla diffusione della religione predicata da Maometto.
Torna all'indice di settore
|