![]()
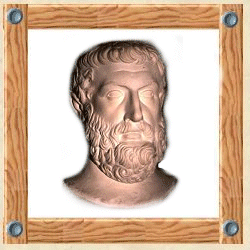
Parmenide,
figlio di Pyres, di ricca e nobile famiglia, svolse un ruolo notevole nella vita
politica della sua città. Secondo Platone, Parmenide sarebbe stato anche ad
Atene intorno al 450 a. C. all'età di 65 anni dove avrebbe incontrato il
giovane Socrate. Si può dunque stabilire la cronologia del filosofo fra il 520
e il 450 a.C.
Parmenide risentì l'influsso della dottrina di Senofane, soprattutto nella
parte riguardante la religione, però a lui spetta il merito di avere costruito
un edificio fra i più complessi dell'antico pensiero greco.
Egli svolse il suo pensiero in un vasto poema in esametri Sulla natura con un
linguaggio semplice, vivo, ma si arricchisce di colori nuovi, di immagini
efficaci, se pure qualche volta un po' astratte. Del poema ci rimangono solo
pochi frammenti, ma alcuni piuttosto ampi ci permettono di capire il modo, in
cui egli trattò la materia. Il poema, diviso in due parti, trattava la Verità,
cioè il concetto dell'Essere, uno e immutabile, mentre la seconda trattava le
opinioni umane, molteplici e mutevoli.
La dottrina dell'Essere parmenideo, pur traendo spunto dal concetto del dio uno
e immutabile di Senofane, acquista caratteri ben definiti e precisi nel corso
della trattazione: esso è ingenerato e indistruttibile, indivisibile e
perfetto, e costituisce l'oggetto unico del pensiero logico.
L'influenza del pensiero di Parmenide fu decisiva per la filosofia eleatica,
soprattutto nei discepoli Zenone di Elea e Melisso di Samo, nonchè nell'opera
di Empedocle; il suo poema costituì oggetto di lettura e di studio per lungo
tempo, come mostra la parafrasi di Sesto Empirico che illustrò le idee di
Parmenide alla fine del II secolo d. C.
Zenone nacque ad Elea intorno al 500 a.C. Il suo pensiero ci è pervenuto
attraverso pochi frammenti, e soprattutto attraverso le testimonianze di
Aristotele e di Sesto Empirico. Si tratta di una serie di argomentazioni volte a
sostenere le tesi di Parmenide.
L'interesse delle argomentazioni di Zenone sta soprattutto nel loro significato
logico.
Le esigenze logiche e l'interpretazione della realtà che la scuola di Mileto ha
fatto valere, si concludono con Melisso di Samo, nella Ionia. Melisso riprende
la tesi parmenidea dell'unità indivisibile dell'essere, fondandola però sul
principio dell'infinità.
Il pensiero successivo sarà impegnato a dimostrare la validità del divenire
del mondo sensibile messo tra parentesi dall'affermazione risoluta dell'unicità
dell'essere; ma non potrà più fare a meno delle conquiste fondamentali che da
quel pensiero sono state acquisite: la realtà come essere, e la possibilità di
ipotizzare l'ordine dell'universo a partire dalle strutture razionali del
pensiero.
![]()