| 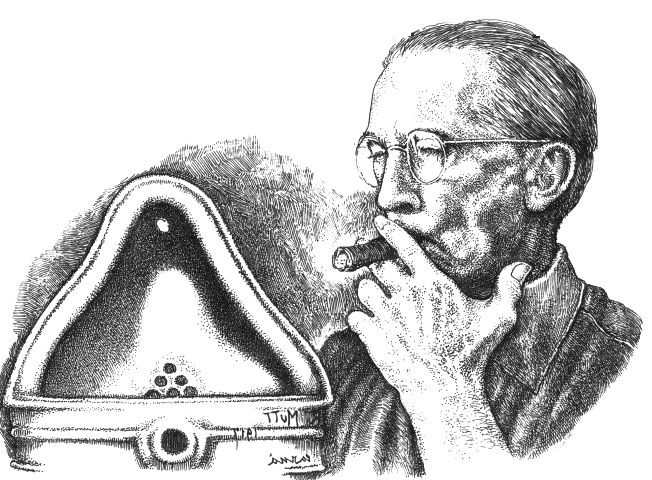 |
Duchamp Shampoo
Ottima lozione per capelli e per cervelli frastornati dal conformismo: ecco a voi la crema di Marcel.
Maìtre-à-penser, maestro d'arte, di vita, soprattutto d'indifferenza. Uno che diceva: «non ci sono problemi perché non esistono soluzioni», e degli altri sapeva fregarsene come pochi. Tutti, ormai, concordano sul fatto che sia lui l'artista più importante del XX secolo, e mentre gli orinatoi vanno e vengono da una collezione all'altra, i telegiornali estivi ne dettero menzione più o meno così: «venduto il celebre orinatoio di Marcel Duchamp, realizzato nel 1917...». Sì, la notizia era vera, una delle tante, ma inesatta e quasi falsa. L'orinatoio più famoso del mondo è stato venduto a maggio del 2002 per la cifra di un milionecentottantacinquemila dollari. Ma quale orinatoio? Un totem sanitario, sradicato da un bagno pubblico, che rappresenta il terremoto estetico del Novecento, l'opera più chiacchierata, adorata o odiata, nonché ossessione morbosa di confronto diretto, come nel caso di Yaun Cain e Jian Jun Xi, i due cinesi che, abbandonata la Cina durante la rivoluzione culturale di Mao, nel settembre del 2000 sono andati dritti all'orinatoio per pisciarci dentro e tentare un'altra rivoluzione: riportare l'oggetto al suo uso, rovesciare di nuovo il rovescio della medaglia, e intorno si gridò allo scandalo e al vandalismo, quasi che l'arte si potesse ribaltare all'infinito senza mai rischiare di essere una puttanata.
E però, sia chiaro, non esiste l'originale dell'orinatoio, chiamato Fountain tanto per confondere le acque. Ciò che si passano i musei e i ben otto orinatoi identici, otto copie dell’originale perduto firmate e prodotte nel 1964 su richiesta di Arturo Schwartz. Sono andati smarriti anche lo Scolabottiglie e la Ruota di bicicletta (entrambi del 1914), semplici oggetti di uso comune che hanno cambiato la storia dell'arte e che Marcel battezzò "readymade", un concetto radicale dal quale sono scaturiti trattati, dibattiti decennali e tutta l'arte contemporanea tout court.
L'idea del readymade sta alla storia dell'arte contemporanea come la ruota sta alla storia della mobilità umana. Si legga, per cominciare, la voce readymade nel Dictionnaire abrégé du Surréalisme: «Oggetto usuale promosso alla dignità di oggetto artistico dalla semplice scelta dell'artista». Marcel Duchamp, una bomba atomica sull'idea di rappresentazione, una bomba intelligente esplosa da quando critica e pubblico hanno cominciato prima a scandalizzarsi, poi a discutere sulle conseguenze filo-sofiche dell'orinatoio, esposto per la prima e unica volta all'Armory Show di New York, nel 1917, e subito rifiutato e scaraventato nella spazzatura. Da allora l'arte non è più stata la stessa.
Da artigianale a gioco, trastullo.
All'artista sarebbe bastato scegliere una qualsiasi cosa e, quella scelta, poiché appunto scelta, sarebbe stata sufficiente a rendere taumaturgicamente ogni cosa opera d'arte. L'arte passava dalla condizione dell'artigianato a quella filosofica, mentale, e anche ludica. La battaglia duchampiana era una battaglia molto più radicale di quanto appaia e ancora attuale, visto che la restaurazione postmoderna sembra consentire tutto e il contrario di tutto, quindi niente. Ma Duchamp ha stravinto. A sbarazzarsi della pittura, facendo fuori l'ideologia vasariana della "buona" e della "cattiva" mano, ci avevano già pensato le avanguardie, dagli impressionisti in avanti. Duchamp fu lì a trarne le conseguenze. Smise i panni del pittore e diventò un genio. Che cos'è il genio? «L'impossibilité de fer», annotò su un bigliettino: l'impossibilità di ferro, dove "fer" suona però come "faire". L'impossibilità di fare. Ma il crollo della pittura è come la morte di Dio, e il sospetto sulla pittura come mezzo troppo convenzionale comincia presto, poco dopo l'avvento della fotografia. L'arte contemporanea è 1 ' arte post-duchampiana che usa le cose, le azioni, le parole come strumenti: Duchamp è ormai universalmente riconosciuto come l'anticipatore di Fluxus, del Neo dada e del New dada (la versione italiana e americana della rinascita dadaista degli anni Sessanta), del Minimalismo, della Pop Art, dei Nouveaux Réalistes, dell'Arte Povera, dell'Arte Concettuale, dell'Optical Art, dell'environmente dell'happening, della Performance Art: insomma, di tutte le (avanguardie e i movimenti più rilevanti di quel secolo splendido e tumultuoso che è stato il Novecento.
Quando Marcel Duchamp si liberò per sempre della pittura dipingendo il suo ultimo olio, Tu m', era il 1918. Tu m' si rivolge alla pittura, sta per "Tu m'infastidisci". Da allora, con rara e aggraziata coerenza, appese al chiodo tavolozza e pennello per non toccarli mai più. Odiava ripetersi, gran parte delle sue opere sono circoscritte tra il 1911 e il 1923, a parte l'installazione chiamata Etant donnés, costruita in segreto negli ultimi vent'anni di vita. Non come Kazimir Malevic, che arrivò al culmine del nichilismo e della pura oggettività con il Quadrato nero su fondo bianco, nel 1913, lo superò immediatamente con Quadrato bianco su fondo bianco, e non sapendo più cosa fare tornò a dipingere, e non solo, tornò persine figurativo, perché il realismo stalinista questo chiedeva. Al suo tocco ogni cosa avvenne oro.
Invece, per Marcel, vita e arte erano naturalmente inscindibili, senza sforzo. Pensiero, rigore e leggerezza. La leggerezza del rigore. Indietro non si tornava mai. E se era crollata la ragion d'essere della pittura, non valeva la pena perseverare soltanto perché ai pittori piaceva dipingere. Inoltre, così come la vita, l'arte era difficilmente comprabile. Quando Duchamp, venticinquenne, arriva a New York senza un soldo, il readymade era una filosofia internazionale. Il giovane Marcel disponeva della magia di fare fortuna con un gesto, anzi una parola, bastava apponesse la sua firma, o una qualsiasi firma, su qualsiasi cosa, e qualsiasi cosa sarebbe diventata oro, sarebbe diventata arte. Ma quando un gallerista gli offrì una cifra vertiginosa per estorcergli qualche readymade, rispose con un "no grazie", e si mise a fare il bibliotecario. Perché i readymade erano una cosa seria, né gusto né mercato, una cosa seria da non prendere sul serio.
I readymade di Duchamp, così come il Grande Vetro -forse il quadro più complicato mai concepito, in realtà s'intitola La Mariée mise ami par ses cé-libataires, mérne, non pittura su vetro ma "ritardo su vetro", e dotato di una scatola d'istruzioni per l'uso piena di appunti, diagrammi, la studiatissima Scatola verde, ennesima beffa alla critica hanno scatenato fiumi d'interpretazioni, di cui lui si liberava sorridendo e facendo spallucce. Amava puntualizzare che i suoi readymade non significavano niente (ed è per questo che significano moltissimo), ma serviva a poco. Il fatidico orinatoio, d'altra parte, non è firmato Marcel Duchamp ma R. Mutt, e quel Mutt per Maurizio Calvesi rimanda alla parola Mutter in tedesco, cioè Madre, evocando la dea madre degli antichi egizi, mentre per Rosalind Krauss alla parola tedesca Armutt, "povertà", e da lì una serie d'interpretazioni alchemiche che l'artista liquidò con fin troppa chiarezza. Perché, per farla breve, Mutt viene da Mott Works, una fabbrica di apparecchi igienici. «Ma Mott era troppo vicino, e allora l'ho modificato in Mutt, perché c'erano dei fumetti quotidiani che pubblicavano allora, Mutt and Jeff, che tutti conoscevano. Volevo un nome indifferente, e ho aggiunto Richard... Richard non è male, per un orinatoio! Ma nemmeno questo, R. soltanto: R. Mutt».
Si guadagnò da vivere anche giocando a scacchi, sua grande passione, perché «se non tutti gli artisti sono giocatori di scacchi, tutti i giocatori di scacchi sono artisti», e restò, quasi suo malgrado, incuriosito da tutto quel movimento di critici, giornalisti e artisti intorno a sé. Visitato e idolatrato come il guru dell'anti-arte, amava piuttosto definirsi anartista, ponendosi domande del tipo: «si possono fare opere che non siano d'arte?”, “Si può fare a meno delle mani?”Non c'è artista, tra gli anni 1950 e 1960, che non sia passato a consultarlo o a rendergli omaggio; non c'è artista che non abbia dovuto lottare con il fantasma di Marcel Duchamp, chi tentando di abbracciarlo, chi di esorcizzarlo.
Eppure, come i readymade diventavano tali per la loro "indifferenza" (né belli né brutti, perché «la bellezza è qualcosa di terribile che una volta accettata finisce per diventare un luogo comune e rassicurante. Nemmeno "brutto" significa nulla, perché è soltanto il bello con un meno davanti. I readymade non ispirano nessun sentimento»), Marcel coltivava l'indifferenza come una virtù speciale, un'uscita di sicurezza dalla banalità del quotidiano.
«Semplicemente, me ne fregavo»
L'aneddotica di vita duchampiana è vastissima, vera o apocrifa cosa importa. Tra gli episodi certificati, tentarono anche d'iscriverlo tra i pacifisti, perché allo scoppio della Prima guerra mondiale se ne andò da Parigi a New York, poco prima di mettere in un'ampolla dell'air de Parìs, e con l'entrata in guerra degli Stati Uniti si trasferì di corsa a Buenos Aires. Tuttavia stiano attenti gli odierni noglobal, antiamericani non interventisti, a reclutare tra le loro file colui che Andre Breton definì «l'uomo più intelligente del mondo». Duchamp fu lapidario. Era pacifista? «No. Semplicemente me ne fregavo». Di Guillaume Apollinaire, che lo indicò come il «possibile conciliatore tra arte e popolo», dirà sdegnosamente: «ne ha dette tante».
Un sorriso lieve e beffardo s'irradiava sul volto di Marcel, simile a quello della Gioconda. Alla esageratamente venerata Monna Lisa, si sa, Duchamp disegnò i baffi, e intitolò l'opera L.H.O.O.Q. (1919), e basta leggere la sigla in francese per avere "lei ha caldo al culo". Svelato l'arcano. Quando Breton pretendeva d'innalzarlo tra i surrealisti militanti, Duchamp lo accusò bonariamente di “attentare alla libertà di respiratore”. A Marcel non interessava l'esistenza di Dio, non gl'interessava né la parola credente né la parola ateo. La sua posizione era molto più semplice e molto più complessa. «Per me c'è dell'altro oltre al sì, no e indifferente - per esempio l'assenza di una problematica di questo genere».
Scovava l'essenziale nell'accidentalità e nell'ambivalenza, allestì un allevamento di polvere, mise il "caso in conserva", di tanto in tanto appariva travestito da donna con lo pseudonimo di Rose Sélavy (il nome alludeva, per anagramma e omofonia, alla frase "Eros c'e-st la vie"}, e gli capitava di affittare un appartamento, in Rue Larry numero 11 a Parigi, e di trovarvi una porta davvero strana: una porta incardinata tra due stanze che se chiudeva il bagno apriva la camera da letto e viceversa, una porta sempre aperta e sempre chiusa. Le cose importanti accadevano per caso.
Diceva anche che si poteva prendere un Rembrandt e usarlo come asse da stiro, prendere un asse da stiro e usarlo come un Rembrandt. Il genio non doveva necessariamente parlare o fare, tantomeno prendere posizione: «la mia è la mancanza assoluta di qualsiasi posizione, e del resto non si può neppure parlare, appena se ne parla si rovina tutto». Il mondo era uno scherzo, la sua stessa arte era uno scherzo e si divertiva, nel suo isolamento dorato, a sentire cosa ne diceva chi lo prendeva troppo sul serio, fraintendendolo due volte. Sapeva di non essere un artista popolare, e non ambiva a esserlo, né temeva di apparire snob. Snobbava chiunque, a partire da se stesso, figuriamoci il pubblico. «Le masse sono ineducabili - diceva Marcel Duchamp - ci detestano e ci ucciderebbero volentieri. Sono gli imbecilli che, unendosi in lega contro gli individui liberi e inventivi, solidificano ciò che chiamano realtà, il mondo materiale così come noi lo soffriamo. Ma tutto lo sforzo dell'avvenire sarà di inventare, in reazione a quello che succede adesso, il silenzio, la lentezza, la solitudine. Oggi ci danno la caccia». E aggiunge: «Lo so, mi tratteranno da reazionario, da fascista... Ma io me ne frego: il pubblico rende mediocre tutto. L'arte non ha niente a che vedere con la democrazia».
Marcel Duchamp morì a Neully, nel sonno, il 2 ottobre del 1968. Dopo aver trascorso la vita a esercitare la libertà del respiro, dopo aver trasformato l'Empire State Bulding in un suo readymade, ha fatto arte persine della sua tomba, sulla quale è scolpita la frase: «D'altronde sono sempre gli altri che muoiono». Sì, sono sempre gli altri, lo pensiamo tutti per vivere. Solo che stavolta, a parlare, è un morto nella sua tomba. Il cadavere di uomo che persine da cadavere non si è preso sul serio. Un cadavere exquis, avrebbero detto gli amici surrealisti.
di Massimiliano Parente
|
