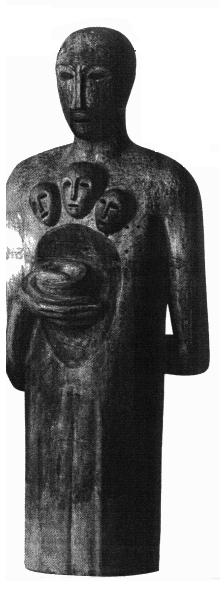| La metamorfosi del mito
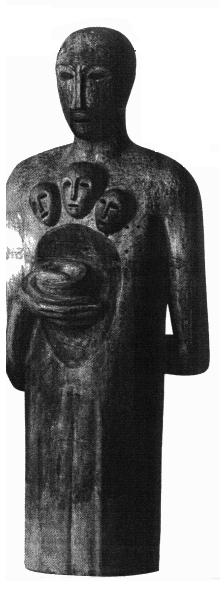 |
Mito, ossia racconto. Continuato, ripreso, rovesciato, annullato. Anche sull'arte del Novecento insistono i miti classici, forza e potenza della storia e delle forme. Il mito è linguaggio oppure forma. Dove alla parola classico si da il significato di tradizione e continuità, persistenza. Secondo il significato che ne dava Thomas S. Eliot nella conferenza su Virgilio del 1944: «Un classico può apparire soltanto quando una civiltà è matura; quando un linguaggio e una letteratura sono mature, e deve essere il lavoro di una mente matura».
Il Novecento riapre gli occhi sopra un'eredità millenaria tramandatasi nel tempo senza scosse. Le avanguardie, una dopo l'altra, abbattono le consue-tudini. Si comincia adagio, attribuendo all'arte significati e finalità nuove, poi i ritmi si accelerano fino a mettere in dubbio tutto.
Sovvertire l'ordine del cosmo
II Futurismo è l'avanguardia delle avanguardie: studiata a tavolino, pensata e programmata, precedette Dada e Surrealismo, seguendo le istanze sparse del Simbolismo che non aveva avutoun principio, un programma di fondazione, ma soltanto assestamenti e volontà di singoli.
Il Futurismo chiese all'arte molto più di quanto sia stato mai preteso. Finse di annullare la storia e la tradizione ma soltanto per ricominciare da capo e ri-costruire il mondo da principi di totalità e vitalità, di ottimismo e invenzione, di allegria, anche.
Il Futurismo assunse i caratteri del suo fondatore, la sua poliedricità, il suo sprezzo del pericolo. Filippo Tommaso Marinetti: soldato, poeta e scrittore, mecenate e impresario, politico e patriota.
Il Futurismo si snodò attraverso tre generazioni e decine di artisti, dalla Sardegna al Friuli, dalla Russia al Giappone. Svolse un programma nato e cresciuto sopra la lettera dei manifesti di fondazione, declinato nelle decine e decine di veci. Si dipinge, si fanno mostre, una dopo l'altra, si scrive, si pubblica, si organizzano serate in tutte le città e Marinetti arriva sempre, in treno, con il suo stiffelius nero.
Il Futurismo sembrò rovesciare sui linguaggi la sua apparente iconoclastia: in realtà Marinetti e i suoi ridettero all'arte l'etica antica di un programma completo e complesso, un impegno.
Il mito dell'arte-vita incrociò quell'ideale che alla fine del secolo aveva attraversato l'Europa, il Gesamtkun-stwerk, l'opera d'arte totale la cui urgenza scaturiva dalle maturità incrociate dei diversi linguaggi. Diventò uno stile di vita eletto ad annullare la distanza tra opera e biografia.
Continuità e memoria
L'idea del mito contemporaneo ha un significato provocatorio. Si tratta di vedere come sopravvivono i miti e l'arte stessa. Dopo il Quadrato nero su fondo bianco di Kazimir Malevic, dopo la Fontaine di Marcel Duchamp, l'orinatoio del 1917, dopo i tagli di Lucio Fontana e la Merda d'artista di Piero Manzoni, dopo l'affermazione hegeliana ormai più che secolare della morte dell'arte.
L'arte va avanti. E propone una ricucitura continua tra ciò che resta dalle reiterate fratture del Novecento e il mondo contemporaneo. Anche il mito resta, e la sua suggestione, la sua continuità tra memoria e tempo. Rovesciandosi, alle volte, diventando l'esatto contrario delle sue origini.
Molti dei miti attuali sono lontane conseguenze dell'anti-mito futurista: rappresentano il capovolgimento delle gerarchie, dei poli energetici, sovvertono il positivo in negativo. Così la città non è più il teatro sperimentale della vitalistica crescita dei futuristi, ma la gabbia del traffico; così la velocità non è più lo sviluppo fantastico dell'epoca della macchina, ma una preoccupante distesa di automezzi fermi in autostrada e la bellezza femminile non è più soltanto oggetto di contemplazione, ma moderno sfruttamento commerciale dell'industria della moda e dello spettacolo.
Tra metafisica e ritorno all'ordine, anni 1910-1920, l'idea e le vestigia del classico tornarono in ogni forma, in ogni ambito, richiamate a forza dalla necessità o dalla nostalgia. Roma e l'antico, l'arte italiana del Tre e del Quattrocento, Masaccio e Paolo Uccello, Piero della Francesca. Si assesta un vocabolario dove la parola classico moltiplica i suoi rimandi. Per Giorgio de Chirico incontrare e dipingere oracoli e Arianne vuoi già dire aver sdoppiato memoria e nostalgia: il mito della Grecia antica si riflette immediatamente nella Grecia di Friedrich Nietzsche: malinconia, enigma, luce del meriggio.
Così i miti s'incontrano, uno e doppio, calco e matrice. E quelli del moderno programmatico ed esperito dai futuristi si aggiungono ai miti che il passato ha salvato, a quel che serve ora: Italia, patria e famiglia, giustizia.
Il tempo, l'immutabile
<o:p> </o:p>Mario Sironi snoda cortei che rivestano la pittura moderna e pubblica di quell’Ethos che l'arte ebbe quando nacque: l'afflato della pittura murale è alto e civile. «Il ritorno alla pittura murale -scrive nel 1932 - significa ritorno agli esempi italiani e alla tradizione nostra, alla quale oggi è impossibile effettivamente collegarsi, nonostante che tanto spesso se ne senta la modernità affascinante e si intuisca la spinta possente che potrebbe venire all'arte moderna dal suo esempio e dalla sua disciplina». Ufficiali come programmi ideali o sotterranei come fiumi carsici, i miti vecchi e i miti nuovi giungono al secolo nuovo.
La mostra Mito contemporaneo ne delinea una mappa possibile attraverso un percorso tematico, suggestioni, accostamenti e proposte che avvicinano artisti dei primi decenni del secolo ad altri delle generazioni successive, fino a quella dei trentenni: Umberto Boccioni, Ottone Rosai, Mario Sironi, Gino Severini, De Chirico, Mino Rosso ed Enrico Prampolini in dialogo con Tano Festa e Mario Schifano, Luigi Ontani, Mimmo Paladino.
La bellezza. Giunge da lontano. Da Felice Casorati, di cui la mostra presenta il superbo Ritratto di Renato Guatino del1922, da Tano Festa che trasforma la quotidianità pop degli americani nella confidente ripresa di Michelangelo. Non minestre, non detersivo in barattolo, ma David e Cappella Sistina: Roma anni Sessanta. Filtra dalla citazione colta e coltivata di Carlo Maria Mariani, artista della classicità quando era peccato impugnare il pennello che risoffia l'anima nelle statue antiche, classiche, neoclassiche, e ancora una volta classiche.
La bellezza si traveste.
È insidiosa e mascherata quella dei set di F.lli Calgaro, ha gli occhioni di Barbie la bella Stefania Ricci che riproduce il suo corpo e lo trasforma in una bambola; ha lo sguardo sfuggente di un'araba affrettata e stupita l'Oriente ventoso di Ali Hassoun che di nuovo prende Michelangelo e lo ritaglia in bianco e nero; mito classico e mito d'Oriente, Roma e Venezia, viaggi, sete, spezie.
Beatrice Buscatoli
|